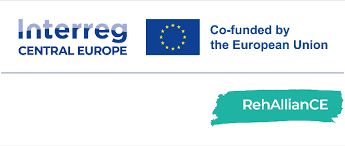Che cos’è la propriocezione e perché è fondamentale per la spalla
La propriocezione è la capacità del corpo di percepire la posizione e il movimento delle proprie articolazioni, anche in assenza della vista. È ciò che permette di eseguire gesti complessi con precisione e sicurezza, come afferrare un oggetto o lanciare una palla, senza dover controllare visivamente ogni movimento.
Sebbene se ne parli molto, la letteratura scientifica presenta ancora una relativa scarsità di dati quantitativi significativi sulla propriocezione, segno di quanto questo ambito resti complesso e in parte inesplorato.
Nel caso della spalla, questa funzione assume un ruolo particolarmente complesso: si tratta infatti dell’articolazione più mobile del corpo umano, e proprio per questo la sua stabilità non può basarsi solo su strutture anatomiche, ma richiede un controllo neuromuscolare costante e raffinato.
Il controllo propriocettivo della spalla coinvolge meccanismi cerebrali e sensori articolari che permettono di integrare informazioni da muscoli e tendini, in particolare dagli stabilizzatori dinamici come la cuffia dei rotatori. Quando si verificano lesioni o instabilità, la riabilitazione mira proprio a enfatizzare queste capacità compensatorie per ristabilire la performance e la stabilità dinamica.
Una propriocezione efficiente consente di mantenere la testa dell’omero centrata nella cavità glenoidea, evitando microinstabilità o sublussazioni durante i movimenti, e di coordinare con precisione l’interazione tra scapola e omero. È fondamentale negli sport di lancio, nel nuoto, nel sollevamento pesi e in tutte le attività che richiedono movimenti rapidi e controllati.
In ambito clinico e riabilitativo, la propriocezione diventa un vero e proprio indicatore di salute articolare: è alla base della stabilità dinamica e rappresenta un parametro sensibile del recupero post-traumatico o post-chirurgico.
Anche nella medicina sportiva, la capacità di riprodurre con precisione un gesto – come il lancio di una palla sempre nello stesso punto, indipendentemente dalla posizione del corpo – è il risultato di un controllo neuromotorio raffinato e di un’efficiente funzione propriocettiva.
Cosa dice la letteratura: evidenze recenti e prospettive
Negli ultimi anni, la letteratura scientifica ha approfondito in modo crescente il ruolo della propriocezione nella funzionalità della spalla, fornendo evidenze sempre più solide sulla sua importanza nei processi di prevenzione e riabilitazione.
Uno dei primi lavori significativi in questo ambito è quello di Laudner et al. (2012) [1], che ha valutato – tramite una macchina isocinetica – la capacità di percepire la posizione nello spazio in soggetti sani ma con iperlassità gleno-omerale anteriore. Lo studio ha mostrato una propriocezione leggermente inferiore nei soggetti più lassisti, suggerendo che il corpo umano possieda un sistema complesso capace di percepire e compensare le variazioni di stabilità articolare.
Uno dei filoni di ricerca più interessanti riguarda la relazione tra lassità gleno-omerale e sensibilità propriocettiva. Studi su giovani atleti, in particolare giocatori di baseball, hanno mostrato che chi presenta una maggiore lassità articolare tende anche a manifestare alterazioni nel senso della posizione articolare [1]. Questo suggerisce che, quando la stabilità strutturale viene meno, il sistema sensoriale tenta di compensare aumentando il controllo propriocettivo, in un meccanismo di difesa contro instabilità e sublussazioni.
Altri lavori, come quelli di Tsuda e colleghi (2021) [2], hanno indagato la propriocezione in pazienti sottoposti a riparazione artroscopica di Bankart. In questi casi, è emerso come i deficit propriocettivi pre-operatori migliorino progressivamente dopo l’intervento e durante la riabilitazione, confermando che la propriocezione non è una funzione statica, ma una capacità allenabile e recuperabile.
Ricerche più recenti, come quelle di Ager et al. (2024) [3] e Alexandrov et al. (2025) [4], hanno inoltre messo in luce il legame tra dolore, instabilità e accuratezza propriocettiva, dimostrando che un miglior controllo sensori-motorio si associa a una minore percezione del dolore e a una maggiore efficacia del gesto motorio. Anche programmi riabilitativi mirati, come quelli proposti da Yoon et al. (2020) [5], hanno mostrato che l’allenamento propriocettivo può ridurre i sintomi di instabilità e migliorare la performance atletica.
Nel loro insieme, queste evidenze scientifiche confermano che la propriocezione rappresenta un parametro chiave della funzione articolare, e che la sua valutazione e il suo allenamento dovrebbero essere integrati sistematicamente nei programmi di riabilitazione della spalla.
Le sfide nella valutazione della propriocezione
Nonostante i progressi compiuti, la valutazione della propriocezione della spalla rimane oggi una sfida complessa. Non esiste uno standard clinico universalmente accettato, e molti dei test utilizzati — come il Joint Position Sense test — si basano sulla capacità del paziente di riprodurre determinati angoli articolari.
Si tratta tuttavia di metodiche altamente soggettive, influenzate dalla collaborazione del paziente, dall’esperienza dell’operatore e dalle condizioni ambientali. La ripetibilità tra sessioni e tra valutatori è spesso limitata, e i dati ottenuti difficilmente comparabili. Il Joint Position Sense test non è particolarmente sensibile né affidabile, e fornisce dati poco solidi sul reale stato propriocettivo del paziente.
A questo si aggiunge la carenza di strumenti oggettivi in grado di fornire misurazioni quantitative continue. Nella pratica clinica, questo significa che spesso non è possibile stabilire in modo preciso se un miglioramento clinico corrisponda anche a un reale recupero del controllo sensori-motorio.
Come osservato anche da Fox et al. (2024) [6], la valutazione propriocettiva viene ancora troppo spesso trascurata, nonostante la sua rilevanza per la stabilità e la prevenzione delle recidive.
Di conseguenza, senza la possibilità di quantificare i progressi del paziente – come si fa per forza, potenza o ampiezza articolare – diventa difficile pianificare un percorso riabilitativo realmente personalizzato e basato su dati concreti.
Dalla ricerca alla clinica: verso una standardizzazione delle misurazioni
La ricerca e la pratica clinica concordano su un punto: per migliorare la riabilitazione è necessario misurare ciò che si vuole migliorare. E’ una delle esigenze a cui risponde AuReha, il dispositivo indossabile sviluppato da DigitalRehab per la misurazione e il training della propriocezione.
Standardizzare la misurazione della propriocezione rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare l’evidenza scientifica e tradurla in pratica clinica.
Disporre di dati oggettivi e confrontabili permetterebbe non solo di validare nuovi protocolli terapeutici, ma anche di definire parametri clinicamente significativi per monitorare il recupero e personalizzare la terapia.
Diversi studi hanno dimostrato come la propriocezione della spalla non è solo un parametro accessorio, ma un vero e proprio indicatore funzionale del recupero motorio [7]. Investire in questo campo, quindi, rappresenta un’opportunità concreta per studiare relazioni tra dolore, instabilità e recupero in modo rigoroso. Strumenti digitali come AuReha aprono la strada a una riabilitazione basata sui dati, più precisa, motivante e integrata con le esigenze del paziente e del terapista.
Conclusioni
La propriocezione è una componente fondamentale della salute articolare e del controllo motorio. Misurarla in modo oggettivo significa comprendere meglio la stabilità dinamica, personalizzare la riabilitazione e prevenire recidive.
L’esperienza condivisa da DigitalRehab al XII International Congress Sport Traumatology “The Battle”, svoltosi il 24-25 Ottobre 2025, conferma come l’unione tra scienza, tecnologia e pratica clinica rappresenti il futuro della riabilitazione.
Attraverso strumenti come AuReha, la valutazione propriocettiva diventa finalmente quantificabile, allenabile e scientificamente validabile, portando la riabilitazione verso un approccio realmente data-driven e centrato sul paziente.
Autori:
Gabriele Fiumana, Shoulder Elbow Team
Elisa Tongiani, Shoulder Elbow Team
Lorenzo Valente, DigitalRehab
Silvia Sciamanna, DigitalRehab
References:
- Laudner K, Meister K, Noel B, Deter T. Anterior glenohumeral laxity is associated with posterior shoulder tightness among professional baseball pitchers. Am J Sports Med. 2012 May;40(5):1133-7. doi: 10.1177/0363546512437522. Epub 2012 Feb 17. PMID: 22343757.
- Tsuda Y, Amako M, Takashima K, Kawaguchi M. Preoperative and postoperative shoulder position sense in patients who underwent arthroscopic Bankart repair for traumatic shoulder joint instability. JSES Int. 2021;5(2):190-193.
- Ager AL, Roy JS, Dubé MO, Cools AM, Borms D. Relationship between pain and proprioception among individuals with rotator cuff-related shoulder pain. J Hand Ther. 2024;37(2):224-233.
- Alexandrov A, Morton A, Molino J, Pelusi J, Chrostek CA, Crisco JJ, Arcand MA. Investigating the Effect of Elevation and Sex-Based Differences on Shoulder Proprioceptive Accuracy. Orthop J Sports Med. 2025;13(2):23259671251315524.
- Yoon JH, Song KJ, Ji MY, Lee BS, Oh JK. Effect of a 12-Week Rehabilitation Exercise Program on Shoulder Proprioception, Instability and Pain in Baseball Players with Shoulder Instability. Iran J Public Health. 2020;49(8):1467-1475.
- Fox JA, Luther L, Epner E, LeClere L. Shoulder Proprioception: A Review. J Clin Med. 2024 Apr 3;13(7):2077. doi: 10.3390/jcm13072077. PMID: 38610841; PMCID: PMC11012644.
- Sayaca C, Unal M, Calik M, Eyuboglu FE, Kaya D, Ozenci AM. Scapular Dyskinesis, Shoulder Joint Position Sense, and Functional Level After Arthroscopic Bankart Repair. Orthop J Sports Med. 2021;9(8):2325967120985207.